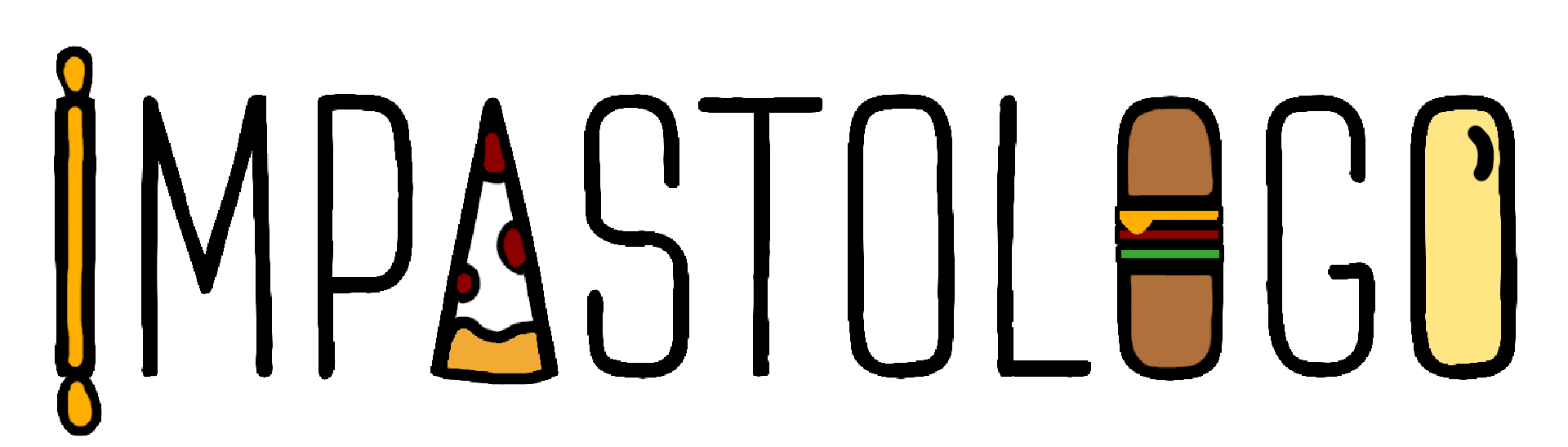L’impasto per pizza alla birra: scopriamo l’origine di questa insolita combinazione L’uso della birra negli impasti per pizza non è una novità così stravagante come potrebbe sembrare. In realtà ha delle basi storiche e ha delle proprietà funzionali all’impasto. n Storicamente, la birra è stata utilizzata nella panificazione fin dall’antico Egitto, quando veniva impiegata al posto dell’acqua. In tempi più recenti, anche i panificatori e pizzaioli dell’Europa centrale e settentrionale erano soliti sfruttare le proprietà della birra negli impasti. nn Funzionalmente, la birra sostituisce efficacemente l’acqua e aggiunge ulteriore umidità all’impasto. Inoltre, grazie al malto presente, fornisce uno zucchero aggiuntivo che alimenta e accelera il processo di lievitazione. n Tra i vantaggi dell’uso della birra citiamo anche il caratteristico colore dorato e gustoso che conferisce alla crosta della pizza. Oggi questa tecnica è stata riproposta e adattata alle alte temperature dei forni. n Io ti suggerisco l’uso di una birra chiara e leggera per non risultare eccessivamente aromatica. n l’impasto per pizza alla birra è un’interessante variante che unisce due piaceri in un unico impasto, sfruttando le proprietà funzionali di questo insolito ingrediente. L’uso della birra negli impasti per pizza ha certamente dei vantaggi funzionali come quello di conferire ulteriore umidità e di accelerare la lievitazione grazie agli zuccheri presenti nel malto. n Tuttavia, potrebbe presentare anche alcuni potenziali svantaggi: nn – Il sapore della birra potrebbe risultare eccessivamente accentuato se non si sceglie attentamente il tipo da utilizzare. Meglio preferire birre chiare e leggere a bassa fermentazione. nn – L’aroma particolarmente accentuato di alcuni tipi di birre artigianali potrebbe non sposarsi bene con tutti i condimenti e mascherarne i sapori. nn – In funzione della birra utilizzata, l’impasto potrebbe risultare più fragile e difficile da manipolare rispetto a uno realizzato solo con acqua. nn – Il contenuto di zuccheri aggiuntivi potrebbe favorire una lievitazione eccessiva che renderebbe l’impasto troppo leggero e digeribile. Come per tutte le varianti, è importante la scelta attenta degli ingredienti e una certa manualità nella lavorazione per sfruttare al meglio i vantaggi senza incappare negli eventuali svantaggi. Con la giusta ricetta e tecnica si può sicuramente ottenere un ottimo risultato.
Il Sale e i Suoi Effetti negli Impasti
Il sale, noto come “oro bianco” della cucina, svolge un ruolo vitale negli impasti per la pizza. Ha molteplici effetti sulle caratteristiche strutturali, igieniche ed estetiche dell’impasto. Prima di esplorare questi effetti, è interessante riflettere sulla storia del sale e sul suo declino commerciale, in parte dovuto alla sua abbondanza e alla facilità di estrazione dalle rocce e dai giacimenti sotterranei, nonché dall’acqua di mare. Il Passato del Sale n In passato, il sale era considerato così prezioso da essere paragonato all’oro e alla seta. Era un bene fondamentale per le economie e poteva scatenare persino conflitti per il suo controllo. Gli Stati monopolizzavano la distribuzione del sale, punendo severamente i contrabbandieri. n Esistono due categorie principali di sale in commercio: il sale marino, ottenuto per evaporazione dell’acqua di mare nelle saline, e il salgemma estratto da giacimenti sotterranei. nn Ruolo del Sale negli Impasti per Pizza n Nell’impasto per pizza, è consigliabile utilizzare il sale marino, poiché conferisce sapore ed ha la capacità di rafforzare la struttura del glutine, specialmente nelle farine a basso contenuto proteico. Il sale interagisce con la gliadina, rendendo il glutine più compatto. Tuttavia, un eccesso di sale renderà l’impasto troppo rigido. La quantità ottimale di sale varia tra il 2% e il 3%. Inoltre, il sale influenza il lievito, riducendo la produzione di anidride carbonica. n Il sale ha proprietà antisettiche e antiossidanti, che contribuiscono a conservare l’impasto per più giorni, impedendo la proliferazione di batteri e ritardandone l’ossidazione. Inoltre, migliora l’aspetto del prodotto finito, conferendo un colore più pronunciato al cornicione e una maggiore croccantezza alla pizza. Dimenticare il sale produrrà un impasto appiccicoso, molle, di scarsa consistenza e difficile da lavorare. Inoltre, la caramellizzazione sarà assente, e vi sarà un eccessivo sviluppo fermentativo. Ruolo del Sale e del Lievito negli Impasti. nn Approfondimento Tecnico n Nell’impasto per pizza, il sale e il lievito svolgono ruoli distinti ma interconnessi, influenzando direttamente le proprietà chimiche e fisiche dell’impasto. nn Il Sale n 1. Potenziamento del Glutine: Il sale marino, contenente cloruro di sodio, interagisce con le proteine del glutine presenti nella farina. Questa interazione è nota come legame ionico, e stabilizza il glutine. Il cloruro di sodio rinforza la maglia glutinica, rendendo l’impasto più elastico e migliorando la sua capacità di trattenere anidride carbonica e gas di lievitazione. Questo è particolarmente utile nelle farine deboli con basso contenuto proteico, in quanto la gliadina, una delle proteine del glutine, è meno solubile in soluzioni saline. n 2. Controllo della Fermentazione n Il sale influenza l’attività dei lieviti. In quantità eccessive, può disidratare le cellule del lievito per osmosi, ostacolando la loro crescita e riducendo la produzione di anidride carbonica. Di conseguenza, una quantità eccessiva di sale rallenterà la fermentazione e può portare alla morte delle cellule di lievito, compromettendo la lievitazione. Pertanto, è fondamentale dosare attentamente il sale negli impasti. Il Lievito n 1. Produzione di Anidride Carbonica n Il lievito è responsabile della fermentazione nel processo di lievitazione. Consuma zuccheri presenti nell’impasto e produce anidride carbonica come sottoprodotto. Questa anidride carbonica è intrappolata nella maglia glutinica dell’impasto, facendolo gonfiare e creando la struttura alveolare desiderata. n 2. Interazione con il Sale n L’equilibrio tra sale e lievito è cruciale. Il sale riduce l’attività enzimatica e la crescita del lievito, ma in quantità moderate, può anche regolare la fermentazione. La presenza di sale limita la produzione di anidride carbonica, impedendo una lievitazione eccessiva che potrebbe sfaldare la struttura dell’impasto. Un contatto diretto e prolungato tra il sale e il lievito può comportare un’indebolimento delle cellule di lievito, quindi è consigliabile evitare tale contatto e aggiungere il lievito in una zona separata dell’impasto. n In sintesi, il sale svolge un ruolo chiave nella modulazione della struttura e del glutine dell’impasto, ma deve essere dosato con attenzione per evitare effetti negativi sulla fermentazione. Il lievito, d’altra parte, è responsabile della produzione di anidride carbonica e della lievitazione. La comprensione di queste interazioni chimiche è fondamentale per ottenere impasti di pizza di alta qualità. Equilibrio tra Gusto e Salute n Infine, è essenziale considerare il giusto equilibrio tra sale nell’impasto e condimento per preservare la salute. La sapidità è importante, ma è responsabilità dei pizzaioli trovare l’equilibrio giusto tra sale nell’impasto e il condimento per soddisfare i gusti dei clienti senza compromettere la salute.
Biscotti di San Gennaro
Oggi voglio condividere con voi una deliziosa ricetta che rappresenta la tradizione culinaria della Campania: i biscotti di San Gennaro! Questi dolcetti soffici e golosi sono tipici della cucina campana e vengono preparati in occasione della ricorrenza di San Gennaro, il patrono di Napoli. La loro origine risale a un tempo in cui erano preparati dalle suore dell’Ospedale San Gennaro dei Poveri, nel rione Sanità. Oggi, grazie al maestro dell’arte bianca Leopoldo Infante, questo dolce è stata riscoperto e amata da tutti. n Gli ingredienti sono semplici e facilmente reperibili. n Per i miei biscotti di San Gennaro: n – Farina 00: 90 gr n – Uova: 2 n – Zucchero semolato: 60 gr n – Lievito vanigliato per dolci: 1 pizzico n – Scorza di limone: q.b. n – Confettura di ciliegie: q.b. n – Zucchero a velo: q.b. n – Vanillina: 1 pizzico Ecco come prepararli passo dopo passo: n In una planetaria, unite le uova con lo zucchero e montate a massima velocità. nn Setacciate farina, lievito e vanillina e uniteli al composto montato. Aggiungete anche la scorza di limone e continuate a montare a velocità minima. nn Finite di lavorare il composto con una spatola. nn Versate il composto con un cucchiaio formando dei piccoli cerchi su una teglia e fate cuocere i biscotti in forno a 200 gradi per circa 7 minuti. Lasciate raffreddare completamente. nn Una volta ben freddi, farcite i biscotti con la confettura di ciliegie e poi accoppiateli. Spolverizzate con un po’ di zucchero a velo e servite. I biscotti di San Gennaro possono essere gustati al naturale o farciti con una golosa confettura a vostra scelta. Potete lasciarvi ispirare dalla tradizione o dare libero sfogo alla vostra creatività! I biscotti si conservano in una scatola di latta o in un contenitore ermetico, a temperatura ambiente, per circa 1-2 giorni. nn Questi dolcetti sono perfetti per ogni occasione, dalla colazione alla merenda, e vi faranno assaporare un pezzo della tradizione campana. Non vedo l’ora di sentire le vostre esperienze e di vedere le vostre creazioni! Taggatemi nelle vostre foto e utilizzate l’hashtag #impastologo n ️
Perché la pizza può causare sete e disagio digestivo
Ciao a tutti gli amici dell’impastologia! Oggi voglio parlarvi di un argomento che riguarda uno dei nostri piatti preferiti: la pizza. Avete mai notato che dopo averla mangiata, può venire una forte sete e la digestione può risultare un po’ difficile? Beh, non siete soli! In realtà, la colpa di questi disagi non è della pizza in sé, ma piuttosto della sua preparazione. Ma cosa succede durante la preparazione della pizza che può influenzare la nostra sete e la digestione? Innanzitutto, dobbiamo capire che la pizza è il risultato di due importanti processi: la lievitazione e la maturazione dell’impasto. nn Durante la lievitazione, l’impasto aumenta di volume grazie all’azione fermentativa del lievito. Questo processo produce acqua e anidride carbonica, che rimangono intrappolate nella struttura proteica del glutine. La lievitazione può avvenire in tempi rapidi, ma è solo una parte del processo. nn La maturazione, invece, è una fase in cui gli enzimi presenti nella farina scompongono gli amidi e il glutine. Questo processo richiede più tempo e dipende da diversi fattori, come la qualità della farina, la temperatura ambiente e il tempo di lievitazione. Con farine forti, ad esempio, il tempo di maturazione si allunga e si rende necessario rallentare la lievitazione, mettendo l’impasto a bassa temperatura per diverse ore. nn Ora, la cosa importante da capire è che una preparazione frettolosa e imprecisa può compromettere sia la lievitazione che la maturazione dell’impasto. Questo può influire sulla digeribilità della pizza e causare sete. Quando l’impasto non è stato adeguatamente maturato, può risultare indigesto e stimolare la sete. Inoltre, l’aggiunta di sostanze rinforzanti o un eccesso di enzimi può avere effetti negativi sulla qualità dell’impasto e sulla sua digeribilità. nn Un altro fattore che può contribuire alla sete è l’eccessiva quantità di sale usata per compensare una scarsa maturazione. Questo difetto può essere subito percepito al palato. nn Oltre alla preparazione dell’impasto, anche la cottura gioca un ruolo importante nella digeribilità della pizza. Una cottura adeguata, con una temperatura elevata, contribuisce a rendere la pizza più digeribile. Quindi, in conclusione, se desiderate una pizza che sia facilmente digeribile e non vi faccia venire sete, è importante prestare attenzione alla preparazione dell’impasto. Assicuratevi di concedere il giusto tempo per la lievitazione e la maturazione, utilizzando ingredienti di alta qualità. Inoltre, evitate l’aggiunta eccessiva di sostanze rinforzanti e controllate la quantità di sale utilizzata. nn Spero che questa spiegazione vi abbia dato una migliore comprensione del motivo per cui la pizza può causare sete e disagio digestivo. Ricordate che la pizza è un’arte culinaria che richiede tempo e attenzione per ottenere risultati gustosi e facilmente digeribili. Buon impasto a tutti!
Affumicatura e bruciatura degli impasti
Considerazioni sulla Salute e Pratiche Sicure: L’affumicatura delle pizze è diventata una tendenza culinaria sempre più diffusa, offrendo un sapore affumicato e distintivo a questo amato piatto. Tuttavia, è importante comprendere le implicazioni sulla salute e adottare pratiche sicure durante il processo di affumicatura. In questo articolo, esploreremo gli aspetti cruciali da considerare per garantire una preparazione sicura e gustosa delle pizze affumicate. Esposizione ai fumi del forno: Alzando la pizza nella platea di un forno a legna per pochi secondi, è improbabile che si conferisca un sapore affumicato significativo all’impasto. L’affumicatura richiede generalmente un periodo di esposizione più lungo al fumo per permettere alle sostanze aromatiche di penetrare nell’impasto e apportare un sapore affumicato distintivo. La pratica di alzare la pizza nella platea del forno a legna serve principalmente a ottenere una cottura uniforme e una crosta ben cotta. L’esposizione al fumo durante questo breve periodo potrebbe apportare solo lievi sfumature di sapore affumicato, ma difficilmente si otterrà un risultato rilevante rispetto all’affumicatura tradizionale. Se si desidera conferire un sapore affumicato più pronunciato alla pizza, potrebbe essere necessario utilizzare altri metodi, come l’utilizzo di legno affumicato o condimenti precedentemente affumicati. Questi approcci offrono una maggiore possibilità di ottenere un sapore affumicato desiderato, ma richiedono una preparazione più specifica e un tempo di cottura adeguato per raggiungere il risultato desiderato. Quando si cuoce una pizza nel forno a legna, è inevitabile che ci sia una breve esposizione ai fumi del legno durante l’alzata nella platea. Tuttavia, diversi fattori influenzano il livello di esposizione e il potenziale impatto sulla salute. È fondamentale assicurare una buona ventilazione del forno per ridurre l’accumulo di fumi e garantire una circolazione d’aria adeguata. La durata e l’intensità dell’affumicatura nel forno a legna sono anche elementi importanti da considerare. Una breve esposizione ai fumi durante l’alzata della pizza nella platea, seguita dalla cottura sulla pietra o sulla griglia del forno, riduce significativamente l’esposizione complessiva ai fumi. Inoltre, evitare bruciature eccessive o carbonizzazioni dell’impasto contribuisce a minimizzare la formazione di sostanze dannose come gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA). Cosa sono gli IPA La loro pericolosità dipende dalla composizione della legna, dalle condizioni di combustione e dal grado di esposizione. Gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) sono composti chimici che si formano durante la combustione incompleta di carbonio organico, come la legna. Alcuni IPA sono classificati come cancerogeni e possono essere associati a un aumentato rischio di tumori, in particolare quelli polmonari e della pelle. La quantità e la pericolosità dei fumi dipendono anche dal tipo di legna utilizzata. La legna secca e ben stagionata produce meno fumo e sostanze nocive rispetto alla legna umida o trattata chimicamente. Inoltre, un’adeguata ventilazione dell’ambiente in cui si svolge la combustione può contribuire a ridurre l’esposizione ai fumi dannosi. Misurazione degli IPA e considerazioni sulla salute: Misurare direttamente la concentrazione di IPA su una pizza può richiedere analisi di laboratorio complesse. Tuttavia, è importante notare che l’esposizione ai fumi di breve durata durante la preparazione della pizza di solito non comporta una concentrazione elevata di IPA. Seguire le pratiche di cottura consigliate, evitare bruciature eccessive e assicurare una buona ventilazione del forno contribuiscono a ridurre al minimo l’esposizione ai composti chimici dannosi. Precauzioni e pratiche sicure: Per garantire una preparazione sicura delle pizze, ecco alcune precauzioni da adottare: – Utilizzare un forno a legna ben ventilato e assicurarsi che ci sia una buona circolazione d’aria. – Scegliere legna di alta qualità, ben stagionata e priva di trattamenti chimici. – Evitare bruciature eccessive o carbonizzazioni dell’impasto. – Monitorare attentamente la temperatura del forno per evitare la formazione di fumo eccessivo. – Seguire le linee guida sulla sicurezza alimentare locali e adottare pratiche igieniche durante la preparazione delle pizze. Qualità del combustibile utilizzato: La scelta del legno per il forno a legna è un aspetto fondamentale per garantire una cottura sicura e salutare. Utilizzare legna di alta qualità, ben stagionata e priva di trattamenti chimici riduce il rischio di formazione di composti dannosi durante la combustione. Legni come quercia, faggio o frutta sono spesso considerati opzioni sicure per l’affumicatura delle pizze. Conclusioni: L’affumicatura delle pizze può offrire un’esperienza culinaria affascinante e saporita. Se seguite le pratiche sicure e le precauzioni appropriate, l’esposizione ai fumi durante l’alzata della pizza nella platea dovrebbe essere di breve durata e a basso rischio per la salute. Assicurarsi di utilizzare un forno ben ventilato, scegliere legna di alta qualità e cuocere la pizza in modo attento sono elementi fondamentali per garantire una preparazione sicura e gustosa delle pizze affumicate. Godetevi le vostre creazioni affumicate con consapevolezza e attenzione alla salute. *Le immagini presenti sono state reperite da fonti web e non sono di mia proprietà.
L’importanza del pH negli impasti
Il pH, ossia il grado di acidità o alcalinità di un impasto, è un parametro fondamentale da tenere sotto stretto controllo quando si preparano prodotti da forno lievitati come pane, pizza, focacce, brioche e tanto altro. Il pH influisce notevolmente sulla lievitazione e quindi sul volume finale, sulla sofficità, sulla fragranza e sulla conservabilità del prodotto finito. misurare e gestire correttamente il pH dell’impasto è indispensabile per ottenere lievitati ben gonfi, morbidi e fragranti. Il pH negli impasti per prodotti da forno lievitati dipende da diversi fattori: – Ingredienti utilizzati: farine con elevato contenuto proteico tendono ad essere più acide, così come i liquidi acidi come il latte e lo yogurt abbassano il pH. – Metodo di lavorazione dell’impasto: impasti lavorati a lungo o sottoposti a ripetute pieghe sviluppano acidità, abbassando il pH. – Presenza di acidi organici: gli acidi prodotti naturalmente dai latticini, dalla frutta e dai lieviti, acidificano l’impasto. – Fermentazione degli amidi: durante la lievitazione gli amidi vengono scissi in zuccheri semplici, andando incontro a fermentazione acida. – Fermentazione dei batteri lattici: i batteri lattici trasformano gli zuccheri in acido lattico, acidificando l’impasto. – Ossidazione dei lipidi: i grassi contenuti nell’impasto possono ossidarsi e formare acidi organici. – Lievito e sale: il lievito tende a rendere l’impasto più acido, il sale ha effetto alcalinizzante. – Metodo di lievitazione: lunghe lievitazioni a basse temperature creano un ambiente più acido. Quando misurare il pH negli impasti Il pH va misurato in due momenti precisi: subito dopo aver amalgamato tutti gli ingredienti, ottenendo quella che in gergo si chiama la “massa d’impasto”, e poi nuovamente nel prodotto finito e cotto, preferibilmente a livello della mollica. Il primo controllo del pH ci permette di verificare l’acidità iniziale dell’impasto e, se necessario, di intervenire aggiungendo acidi o alcali per riportarlo nel range ottimale. Il secondo controllo nel prodotto cotto serve invece a capire come il pH si è evoluto durante la lievitazione e la cottura, fornendoci preziose informazioni per migliorare il processo. Come misurare il pH dell’impasto Per misurare il pH dell’impasto appena amalgamato, il metodo migliore è utilizzare un pratico pH-metro da cucina, facile da reperire e da usare. In alternativa, si possono utilizzare delle apposite cartine tornasole per alimenti, che cambiano colore a seconda del pH. Nel prodotto finito, la misura va eseguita sulla mollica, che deve essere tritata finemente e mescolata con poca acqua distillata per ottenere una soluzione liquida su cui poter immergere la sonda del pH-metro o la cartina tornasole. È importante che la misura avvenga sempre a temperatura ambiente. Qual è il pH ideale negli impasti? Ma vediamo quali sono i valori “giusti” di pH a cui dobbiamo mirare. Per una buona lievitazione, con una temperatura ambiente sui 25°C, il pH ottimale per l’impasto si aggira intorno a 5-5,5 al massimo 6. Valori superiori a 6,5 rallentano notevolmente l’attività dei lieviti, mentre sotto 4,5 i lieviti tendono a morire e la lievitazione ne risente pesantemente. Anche la temperatura incide parecchio: con 15°C di ambiente il pH ideale scende a 5-5,5, mentre a 30°C può salire fino a 6-6,5. Analizziamo più nel dettaglio le conseguenze: pH troppo acido (sotto 5) – I lieviti vengono inibiti e non riescono a svolgere bene la loro azione lievitante. L’impasto si gonfierà poco. – Le proteine del glutine non coagulano bene, assumendo una consistenza appiccicosa e poco elastica. L’impasto risulterà appiccicoso. – I composti responsabili del sapore e dell’aroma non si sviluppano appieno. Il prodotto avrà un sapore piatto. – C’è un maggiore sviluppo di batteri acidificanti che accelerano il deterioramento dell’impasto. pH troppo alcalino (sopra 6.5) – L’attività dei lieviti rallenta, così la lievitazione è più lenta. L’impasto si gonfia con difficoltà. – Le proteine del glutine si aggregano troppo fra loro. L’impasto perde elasticità e tende a diventare gummoso. – Anche in questo caso aroma e sapore risultano attenuati. – La solubilità delle proteine è ridotta. L’impasto assorbe meno acqua, risultando consistente e duro. – La conservabilità è minore rispetto a un pH ottimale tra 5 e 6. La temperatura “ideale” per il ph La temperatura è un fattore molto importante da considerare quando si misura e si gestisce il pH negli impasti lievitati. Ecco spiegato perché: – L’attività dei lieviti è influenzata dalla temperatura. A temperature più alte i lieviti lavorano più velocemente, a temperature più basse rallentano. – Di conseguenza, il pH ottimale cambia a seconda della temperatura di lievitazione. Con impasti a 15°C il pH ideale è sui 5-5,5, a 25°C sale a 5,5-6 e a 30°C arriva a 6-6,5. – Gli enzimi del lievito che scompongono amidi e proteine in zuccheri fermentescibili lavorano meglio a temperature tra 25-30°C. Sotto i 10°C la loro attività è molto ridotta. – Le proteine del glutine che conferiscono tenacità ed elasticità all’impasto coagulano meglio a temperature fra 25-30°C. Sopra i 30°C tendono a coagulare troppo. – Gli acidi organici che contribuiscono al sapore vengono prodotti maggiormente tra 25-30°C. Temperature più alte o più basse ne limitano la produzione e il sapore risulta piatto. – Anche la velocità di molte reazioni chimiche che avvengono durante l’impasto e la lievitazione aumenta al crescere della temperatura. Per tutti questi motivi monitorare temperatura e pH in parallelo è indispensabile per una buona lievitazione e per prodotti finali ottimali. Come correggere il pH dell’impasto Qualora rilevassimo un pH troppo acido o troppo alcalino, esistono diversi metodi per riportarlo nel range ottimale e salvaguardare lievitazione e qualità del prodotto finito. Per aumentare il pH e rendere l’impasto meno acido, possiamo aggiungere bicarbonato o lievito chimico. Viceversa, per abbassare un pH troppo alcalino e acidificare la massa, sono indicati acidi come l’aceto, il latticello o il lievito acido. Attenzione però a non esagerare con le quantità, poco basta. In conclusione, monitorare e gestire correttamente il pH è un passaggio fondamentale per ottenere dai nostri impasti lievitati degni di un vero artigiano, dalla sofficità e fragranza impareggiabili. Armandoci di pH-metro e cartine tornasole possiamo finalmente ottimizzare i nostri impasti ed esaltarne al massimo le potenzialità.